Premessa:
Anche quest’anno al festival del cortometraggio di Oberhausen c’erano una gran quantità di titoli di ogni genere, tra competizioni nazionali e internazionali, film di finzione e sperimentali, animazioni e videoclip. A mio parere le sezioni più interessanti restano quella dei profili dedicati a singoli autori (quest’anno Mara Mattuschka, Aryan Kaganof, Wojciech Bąkowski e Deimantas Narkevičius) e quella sugli archivi (a mostrare perle delle proprie collezioni e presentare le proprie politiche di restauro e conservazione c’erano la Filmoteka Muzeum di Varsavia, l’Harvard Film Archive, l’EYE di Amsterdam e Robert Beavers con il Temenos, che raccoglie le opere di Gregory Markopoulos e dello stesso Beavers). Tuttavia ho deciso di non parlare di questi come di altri pur interessanti programmi, e concentrarmi invece sulla sezione “Thema”, che come ogni anno percorre il festival con diversi programmi raccolti attorno a un’idea centrale. Mi sembra interessante che il festival, per festeggiare i suoi sessant’anni, al di là del ricco banchetto di titoli offerto, abbia messo al centro questa rassegna che, a prima vista, si presenta come una tavola non apparecchiata.
Entro in sala, una delle cinque che compongono il Lichtburg, nel centro di Oberhausen, da tempo sede principale dei Kurzfilmtage. Su ogni poltrona si trovano alcune brochure con la programmazione ordinaria del multisala: film che avrei potuto vedere anche in Italia, altri che non vedrò mai – non si spiega cosa ci facciano qui questi fogli, in una sala gremita da un pubblico per lo più composto da registi, curatori e critici con tutt’altri programmi in testa. Si spengono le luci, il proiettore illumina lo schermo e poi… niente, la luce continua a battere sulla tela bianca, dal fondo si percepisce qualche sommovimento, risate sommesse, poi piccole ombre che sfrecciano rapide sullo schermo: aeroplanini di carta (le brochure) volano in ogni direzione lanciati e rilanciati dal pubblico. Hell’s Angels, performance che Ernst Schmidt Jr. presentò nel 1969 con un’ironica dedica all’aviatore Howard Hughes, individua con leggerezza ed esattezza lo spazio sospeso tra proiettore e schermo in cui prende vita e senso la sezione “Thema”di quest’anno, curata dall’artista e filmmaker finlandese Mika Taanila: “Memories Can’t Wait – Film Without Film”.
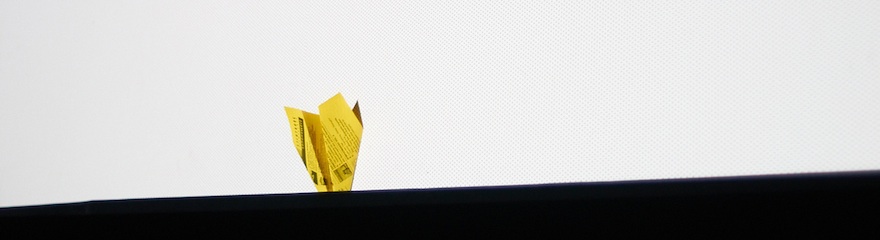
Una proiezione mancata, trasformata in un momento di intervallo e ricreazione, una trasgressione delle consuetudini che resta però entro i confini della sala: la performance di Schmidt è stato per Taanila il primo spunto per una rassegna che assume la sala come un tempo e uno spazio specifici in cui operare in modo non specifico, con programmi che non si lasciano semplicemente eseguire, ma si pongono piuttosto come sospensioni e deviazioni di quel flusso rassicurante che permea il cinema ogni volta che viene attivato il proiettore. L’obiettivo, nel complesso, è rovesciare le parti consuete, quelle assegnate dal dispositivo: fare il vuoto sullo schermo per far sentire il pieno latente della sala, amplificare il lavorio sommesso di quell’ingranaggio essenziale nella macchina desiderante del cinema che è il pubblico. Si tratta di pensare al film senza il suo supporto fisico, non tanto e non solo la pellicola in sé (che è già un fantasma nei cinema di oggi), ma la stessa proiezione, il movimento delle immagini, insomma ciò che dà corpo all’esperienza di un film: pensare a un’esperienza senza più corpo. Il pubblico davanti allo schermo diventa al tempo stesso materia prima e agente di questa esperienza.
“C’è troppo da vedere qui, voglio vedere di meno.” Così Hollis Frampton davanti al rettangolo di luce bianca che per tutta la durata di A Lecture[i] viene ribattuto sullo schermo da un proiettore non caricato. La famosa conferenza-performance è qui ricostruita come si svolse all’Hunter College di New York nel 1968 – Taanila al proiettore, al posto che era di Frampton, e un nastro registrato col testo letto da Michael Snow – all’interno di un programma dedicato a quest’ultimo, che comprende anche A Casing Shelved (1970), sorta di film autobiografico condensato in una diapositiva, quella di uno scaffale nello studio dell’artista carico di oggetti, che la voce di Snow descrive minuziosamente intrecciandoli alle proprie vicende. Ma torniamo allo schermo bianco di Frampton: la luce cristallina, che arriva sulla tela senza incontrare alcun corpo, fissa un grado zero del film che è al contempo una totalità: “È solo un rettangolo di luce bianca. Ma è tutti i film. […] non potremo mai vedere qualcosa di più, ma soltanto di meno”; qualsiasi cosa sia frapposta tra il fascio luminoso e lo schermo (ad esempio un film) è infatti una sottrazione da questa bianchezza che comprende l’intero spettro della luce e delle possibilità. Il cinema, così come lo conosciamo, comincia con questo gesto di riduzione: “l’arte cinematografica consiste nell’escogitare cose da mettere dentro al nostro proiettore.”
La tabula rasa di Frampton è un ideale punto di arrivo per questa rassegna, che tenta appunto di pensare a “cose” da mettere dentro al proiettore che non siano quegli artefatti chiamati film. Come ad esempio un filo da cucito, che scorre tra gli ingranaggi del proiettore in zzz: hamburg special (1968), così intitolato da Hans Scheugl perché fosse sempre all’ultimo posto di ogni filmografia, un film tanto materico da divenire astratto, dove l’unico attore è un corpo sottile che fila alla velocità dei fotogrammi, una linea nera inquieta che si agita da una parte all’altra del grande schermo. I reticoli di ombre prodotti da Tony Hill in Point Source (1973), invece, non si accontentano dello schermo e dilagano per tutta la sala avvolgendola: nessun proiettore, ma una piccola torcia che esplora diversi oggetti tra le mani dell’artista. Si oscilla così tra immersività e smaterializzazione, tensione contraddittoria e caratteristica di un cinema che si espande, guadagna spazio mentre assottiglia la propria presenza fisica, scivolando dolcemente verso l’immateriale.

Un film che non si lascia afferrare, localizzare, eppure insiste sulla situazione della sala, la pervade; il cinema expanded si converte così in un cinema contratto, ridotto a particelle che entrano nei pori della séance cinematografica, come minuscoli inneschi di energia psichica: un film che il pubblico deve alimentare senza poter mai esaurire. Cinema “infinitesimale” come quello teorizzato e praticato dai lettristi: “Il film è la vostra respirazione” recita un foglio consegnato all’ingresso in sala, dichiarazione che è l’unico supporto su cui si regge Respirez (1968) di Roland Sabatier, film impalpabile, inimmaginabile in sé, ma “trampolino per l’immaginazione”. Similmente in Entrac’te (1969), altro film ‘dichiarato’ di Sabatier, una scritta su un foglio fotografato e proiettato annuncia che “la colonna sonora, è rappresentata dalla somma dei rumori, delle parole e dei pensieri emessi dall’insieme degli spettatori riuniti attorno all’immagine.” Il negativo di questa situazione potrebbe essere un film acustico come Wochenende (1930) di Walter Ruttmann, il primo nella storia a scorrere nel buio più completo: un radio-dramma rumorista montato sulla colonna sonora ottica di una pellicola 35mm e pensato per essere ‘proiettato’ in sala. “Tutto ciò che è udibile diventa materiale” scriveva Ruttmann un anno prima a proposito dell’avvento del cinema sonoro, probabilmente pensando già a questo lavoro di musica concreta ante-litteram, che nella discontinuità materiale del suo collage sonoro è molto più affascinante delle astrazioni decorative in cui scadono a volte le sinfonie visive del regista.
Ovviamente le regole che il curatore si è imposto con quel “without” sono fatte per essere aggirate e anche dei film veri e propri, su supporto analogico e digitale, sono inclusi nella selezione; anzi, sono forse proprio le opere che conservano una tensione tra aspetto meccanico e performativo della proiezione a risultare le più interessanti. Un classico in questo senso è Projection Instructions (1976) di Morgan Fisher, che consta effettivamente di cartelli con istruzioni (come “sposta il quadro in basso” o “metti la lente fuori fuoco”) che il proiezionista deve eseguire mentre il film scorre. Dalla passione strutturale degli anni Settanta, benché da un altro contesto (quello della London Film-Makers Coop), proviene anche William Raban, presente con due storiche performance che fanno collidere il tempo registrato del film e quello vissuto nello spazio del cinema. 2’45’’ (1972) apre un vuoto ricettivo nella sala, simile a quello dei 4’33’’ di John Cage cui esplicitamente si ispira: sul fondo una cinepresa registra lo schermo vuoto e le reazioni del pubblico per la durata di un rullo di pellicola, all’epoca un 16mm sonoro (2’45’’ appunto); nelle sessioni successive la prima registrazione è proiettata e ripresa a sua volta nello stesso modo, stratificandosi progressivamente in una mise en abyme di schermi vuoti. Benché Raban, anche per ragioni logistiche, si sia qui servito di una camera digitale, e non della pellicola come sempre aveva fatto per questo pezzo, la struttura scaglionata (all’epoca indispensabile per sviluppare la pellicola) è conservata: il tempo differito del cinema incurva il tempo reale che la trasmissione video consentirebbe. L’accento posto sulla materialità del film consente insomma di condensare lo spazio e il tempo della sala e “prendere le misure”, come Raban fa letteralmente nell’altra sua performance, Take Measure (1973), dove il nastro di pellicola è srotolato dal proiettore in cabina fino allo schermo e poi proiettato per la durata del suo riavvolgimento attraverso la sala: il film mostra un contatore che certifica la lunghezza del nastro stesso.
.jpg)
Uno dei lavori più interessanti in rassegna è un altro film che lavora sulla linea fisica e immaginaria che collega proiettore e schermo: Projector Obscura (2005) di Peter Miller è realizzato con pellicola impressionata dentro a proiettori riconvertiti a camere oscure, che riprendono lo schermo verso cui sono puntati, assorbendo la luce anziché proiettarla; reversibilità che era del resto proprietà originaria del cinematografo Lumière, un apparecchio per “riprendere e ridare i film” (per dirla con Stan Brakhage). In queste inversioni e deviazioni è del resto facile sprofondare nella stratigrafia dell’apparato cinematografico, incontrare fossili che presentano qualche affinità con esso, ma soprattutto suggeriscono che la sua attuale composizione non è, né è mai stata, necessaria e definitiva. L’archeologo dei media Erkki Huthamo intrattiene con una conferenza sul panorama mobile ottocentesco, che per tanti versi è una delle massime approssimazioni al film prima del film, mentre Daniel Barrow sembra un erede dei vecchi lanternisti: grande affabulatore, illustra, proietta e anima storie intrise di ironico decadentismo, servendosi con eleganza e fluidità di un medium povero come la scolastica lavagna luminosa, ormai un reperto tanto quanto la lanterna magica, che, oltretutto, Barrow nemmeno conosceva quando ha cominciato a costruire questi bizzarri e personalissimi show and tell.
Come si può intuire, la selezione di Taanila è necessariamente eclettica, non sempre azzecca il tiro, soprattutto con alcuni lavori commissionati per l’occasione, ma nel complesso dimostra il giusto grado di intelligenza e leggerezza per tenere fede al paradosso del “film senza film” senza appesantirlo del carico concettuale e storico evocato da una simile impresa. Conservando un equilibrio tra omaggi storici e proposte contemporanee, si ipotizzano percorsi alternativi, scorciatoie e vicoli ciechi, che scartano il film in quanto tale e lasciano invece fluire in sala quello che dovrebbe essere il derivato emotivo della visione film: ricordi che “non possono aspettare”. Se ogni film proiettato in sala comporta “l’esperienza vissuta in tempo reale di un processo cumulativo di memoria e dimenticanza”[ii], il paradosso temporale evocato dal titolo sembra suggerire una torsione della memoria: ricordi non aspettano di diventare tali, come se volessero entrare d’anticipo sul gioco di affetti del film, irrompendo in sala e sovrapponendosi alla stessa esperienza di cui dovrebbero essere traccia. Qui il film è stato dimenticato, fin dall’inizio, del tutto; ed è tutto da ricordare.
L’accento sulla dimensione memoriale innescata da questi fantasmi di film mostra quello che è forse il risvolto più contemporaneo di questa rassegna: soprattutto in alcuni momenti, quelli che invocano più esplicitamente l’attivazione e la partecipazione del collettivo in sala, si sente tutta la distanza rispetto ai valori estetici, ma anche sociali, che queste parole rappresentavano al tempo delle prime esperienze dell’expanded cinema, tra anni Sessanta e Settanta; quello che sembra emergere qui (non parlo certo delle intenzioni del curatore, ma dei risultati) è piuttosto una passività dei corpi, abbandonati sulle poltrone, abbandonati dal film e lasciati sospesi nel rumore di fondo di pensieri, impressioni e, appunto, ricordi. Una rilassatezza ‘attiva’ che induce non tanto a partecipare, ma a farsi da parte, godersi l’assenza del film nella propria stessa assenza, perfezionare quel vuoto. Spettatore e film sono accomunati dalla disponibilità a ricevere e trattenere delle impressioni; ma la memoria dello spettatore contemporaneo (si conceda l’astrazione) appare affetta da un eccesso di impressioni, sempre più frequenti e frammentarie, sempre meno incisive. Se l’esperienza del film in sala è ormai diventata qualcosa di raro, di ricercato, l’esperienza della sala senza film è un vero e proprio lusso, ma anche un antidoto a questo senso di saturazione. Il desiderio impossibile, cui sembrano accennare alcune di queste opere, è quello di una memoria nuovamente liscia, come pellicola non impressionata.

“C’è troppo da vedere qui, voglio vedere di meno.” Il bianco dello schermo non rappresenta solo il campo di infinita possibilità indicato da Frampton nella sua conferenza; può anche essere la massa lattiginosa in cui tutti i film si accumulano, si mescolano, si disperdono: il pieno insostenibile della storia (delle storie) del cinema. Quello che nella visione “metastorica” di Frampton era una virtualità che contiene tutti i film (quelli che sono ancora e sempre da farsi, per sottrazione), si presenta oggi come una sorta di inquietante rovescio: il rumore bianco prodotto dall’attualità, un bianco da sovraesposizione; lo stesso che si può scorgere nelle sale deserte dei Theaters di Hiroshi Sugimoto (1978), fotografie che assorbono l’intera durata del film in una sola lunga posa, restituendo il bianco spettrale di uno schermo che ha risucchiato tutte le immagini.
[i] Hollis Frampton, “A Lecture” (1968), in: On the Camera Arts and Consecutive Matters. The Writings of Hollis Frampton, a c. di Bruce Jenkins, Cambridge MA: MIT Press, 2009; trad. it. di Ottavio Fatica in: Adriano Aprà (a c. di), New American Cinema. Il cinema indipendente americano degli anni Sessanta, Milano: Ubulibri, 1986, pp. 73-76. Testo originale e versione italiana ora in: Hollis Frampton, Bruce McClure, A Lecture / Know Thy Instrument, Milano: Split Editions/Atelier Impopulaire, 2014, pp. 10-24.
[ii] Raymond Bellour, “Le spectateur de cinéma: une mémoire unique”, Trafic, 79, autunno 2011, p. 38.