Qualcosa si sta insinuando da qualche tempo tra le pieghe del cinema italiano. Un’aria che anch’io respiro, non essendo un critico, ma un "abitante" dell’altra parte, tra quelli che cercano di fare cinema. Qualcosa che sento lieve ma costante, come i pollini a primavera. È un’aria gravida e piacevole, anche se ancora poco respirabile. La tendenza all’autarchia, l’attenzione a vicende marginali, lo sprofondamento nel linguaggio, il disinteresse per i formati standard. Così posso riassumere in modo molto generico quello che intendo.
Non dico nulla di nuovo, ovviamente. Da sempre il cinema si dirama ovunque e le sue derive estreme sono state innumerevoli e svariate. Ma ciò che sta succedendo ora ha una particolarità, una caratteristica fondamentale, mai forte come ora: l’intenso rapporto con il reale, inteso nel senso più vasto: sia come quotidianità politica, sia come ambiguità per eccellenza, come istanza filosofica. Reale che viene colto per quello che è – un’apertura nel/del mondo – fuggendo il realismo e la falsa oggettività, e che è considerato al pari dell’elemento di finzione, in un proficuo gioco, come ammonisce Comolli (Vedere e potere. Il cinema, il documentario e l'innocenza perduta, Roma, Donzelli) : “La finzione in realtà, il realismo nel fantastico, il vero nel falso, il dentro nel fuori, il diritto nel rovescio, attimo dopo attimo”. Questi film sanno lasciare la briglia sciolta al caso e al contempo mettono in atto una rigorosa pratica di linguaggio, che spesso coinvolge direttamente lo stesso filmmaker (ad esempio utilizzando una voce off in prima persona, oppure mettendo in scena il corpo dell’autore, oppure semplicemente usando uno stile proprio), in quanto parte del mondo e contemporaneamente artefice del discorso.
Questa tendenza vive ovviamente ai margini del cinema mainstream, ma anche di quello sperimentale e documentario. Questo cinema si occupa, questione radicale tout cour, del rapporto che si instaura con il tempo della registrazione (il tempo che passa): spesso si assoggetta a ciò che il reale dona o sottrae, vero e proprio ‘luogo’ sovraccarico di derive, echi, che l’autore si permette di trasformare in segno, in simulacro, in geroglifico, portando all’estremo il già incrinato rapporto tra fiction e documentario, definendone decisamente il sorpasso a favore di qualcos’altro che prima o poi verrà definito accademicamente.
Autori che seguono un percorso rigido, altri che toccano questa tendenza una sola volta, altri indecisi che stanno a cavallo tra diverse possibilità. Michelangelo Frammartino, Pietro Marcello, Giovanni Cioni, Andrea Caccia, Giovanni Maderna, Carlo Michele Schirinzi, Davide Arosio e Alberto Gerosa, Mirko Locatelli e molti altri. Autori estremamente diversi.

Ad esempio Michelangelo Frammartino con Le quattro volte supera decisamente la barriera fiction/documentario, sfruttando la realtà come laboratorio di segni che rimandano sempre a qualcos’altro, chiusi in una rigida rappresentazione fatta di piani sequenza e pochi importanti movimenti di macchina, di inquadrature rigorose che non tendono a sezionare lo spazio, ma a offrirne una reiterazione, quasi a voler sottolineare come nello spazio stia accadendo sempre qualcosa. Oppure Andrea Caccia che indaga, in La vita al tempo della morte, l’ineffabile tema per eccellenza, la morte, attraverso tre punti di vista (riprese dal vero, interviste, autoritratto), girati in tre formati diversi (digitale, HD e pellicola) che non fanno che sottolineare l’inutilità della ricerca di un senso, poiché la stessa presenza delle cose dovrebbe far scaturire il cosiddetto senso. O ancora Il primo giorno d’inverno, esordio al lungometraggio di Mirko Locatelli, film più classicamente fiction, ma costruito in modo che il reale possa continuamente disturbare e decentrare il racconto: gli attori non professionisti, le location dal vero, i piano sequenza sempre strettamente legati ai protagonisti e ai loro atteggiamenti. La storia, che tratta di ordinarie difficoltà di vita adolescenziali che sfociano in tragedia, si sfilaccia dando spazio a momenti quotidiani, spesso statici, che hanno a volte più tensione del racconto vero e proprio dell’azione, alla quale si affiancano. I giovani si muovono, o semplicemente respirano, con la difficoltà che gli è propria, senza nascondere i propri balbettii e l’insicurezza di un corpo che va formandosi. Tre esempi, frutto di esigenze diversissime, ma allo stesso tempo con una regola comune: non scendere a compromessi. Nella loro ostinazione (particolarmente evidente se si dovesse studiarne le complicate e impossibili vicende produttive) fanno del reale uno strumento d’indagine e non un luogo d’indagine.

Un cinema che sperimenta, ma lontano dal cinema sperimentale in senso stretto, almeno se lo si intende legato alla speculazione sulla percezione. Il cinema sperimentale spesso non vuole comunicare direttamente, non vuole un incontro empatico, ma una riflessione o una esperienza sul (e del) medium stesso. Pensiamo ad alcuni autori del nostro tempo come Flatform, Giuseppe Boccassini o Davide Pepe. Le loro opere, originalissime, tendono spesso allo sconvolgimento percettivo, ma il reale, quando c’è, è al servizio di qualcos’altro. Basti pensare a Osceno di Giuseppe Boccassini: il regista filma direttamente da uno schermo la proiezione di alcune scene di un film pornografico, ricostruendo l’inquadratura, applicando filtri, reinventando il montaggio. Il risultato è molto affascinante e straniante. I corpi diventano continui movimenti immateriali, giochi di tinte e di geometrie che ci portano nell’astratto, ma allo stesso tempo la matrice, l’atto sessuale, è più o meno sempre evocata. Però la frammentata e distorta riconoscibilità dei corpi ci distanzia dall’idea di sesso e di voyerismo, smontando la ripetitività dell’atto e facendolo diventare un movimento senza più scopi immediati, in cui la carne sembra essere un colore non identificabile che si modifica repentinamente. Più che il grande pittore Francis Bacon, che il regista cita esplicitamente in alcune inquadrature, il film ricorda gli incredibili amplessi “sincronici” di Naked Lunch di William Burroughs, la cui ripetizione all’infinito, sempre in modi estremi, crea una sorta di inedito linguaggio dei segni basato sul ritmo. La realtà, anche quella più bassa è rappresentata non perché possa svelare in sé qualcos’altro, ma perché possa cambiare la nostra percezione della rappresentazione artistica, in questa continua ri-presentazione di un gesto umano attraverso incessanti rifacimenti (il rifilmare, i filtri, il ri-montaggio), che alla fine diviene logoro e perde il suo scopo primigenio.
Ci sono eccezioni nell’ambito del cinema sperimentale contemporaneo: Carlo Michele Schirinzi è autore in tutto e per tutto sperimentale, che però raccoglie la sfida lanciatagli dalla realtà. Già conosciuto come artista figurativo (sempre legato al video o all’immagine riprodotta), Schirinzi nei primi lavori si mette in scena come protagonista di vicende folli in cui spesso è riconoscibile l’architettura e la paesaggistica del Salento, suo luogo d’origine e sua casa. Ne Il Nido, forse uno dei suoi film più accessibili, interpreta un cleptomane che s’aggira per le vie del suo paese d'origine, Acquatica del Capo, rubando e accatastando in modo compulsivo oggetti inutili.
L’autore cura la realizzazione dei suoi film in solitudine, dando la sua presenza in tutti i ruoli quasi come sfida, come costrizione artistica. Il reale entra in questi suoi primi film semplicemente come eco, come deriva della realtà: oggetti abbandonati, film porno ritrovati, il proprio corpo ‘scovato’ tra spazi angusti dovuti alle inquadrature fisse e alla sua abitazione, vecchi filmini di guerra. Pezzi di vita abbandonati in un mondo che si consuma e sporca. All’erta, Dal Toboso, Oligarchico: ecco alcuni tra i moltissimi titoli di questa prima fase artistica. L’ascendenza di Carmelo Bene è chiara (Hermitage più di tutto), ma mai pedissequa.
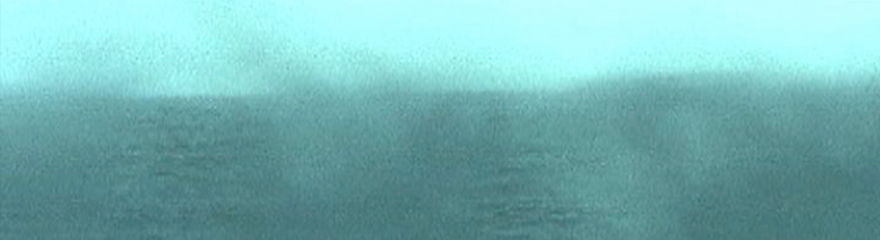
Nei film più recenti il corpo di Schirinzi lentamente sparisce, lasciando posto sempre più al reale fuori da sé, fino a quello più contingente e più vicino a lui geograficamente: la questione dell’immigrazione clandestina. Schirinzi sceglie di togliere di mezzo il clandestino sofferente, l’uomo sofferente: volto ormai troppo rappresentato dai media e dal loro potere d’appiattimento, la cui funzione è inutile, il nostro autore riparte dalla definizione stessa di clandestino, ricreando la nostra percezione. Ad esempio Mammaliturchi! mette in scena un ex centro d’accoglienza distrutto, in cui le tracce lasciate dagli accolti e dagli accoglienti, andati chissà dove, vengono filtrate attraverso una visione che traballa tra estremamente oggettiva (panoramiche imperfette e lunghissime, filtri apparentemente casuali, dettagli immobili) e estremamente soggettiva (a causa delle stesse panoramiche imperfette e lunghissime, degli stessi filtri casuali, degli stessi dettagli immobili), alternate a una inquadratura del mare ripresa dalla spiaggia che diviene ad ogni stacco sempre più astratta, fino a sembrare, nell’ultima, un quadro di Rothko. Un punto di vista fluttuante ma allo stesso tempo preciso nel suo essere sperduto, come una barca in mare aperto : “l’intero film è la visione d’apnea del cadavere di uno dei viaggiatori custoditi dai mari” (nell'intervista di Molinaro all'autore http://cinemio.it/film-italiani/registi-emergenti-carlo-michele-schirinzi-prima-parte/7506/). Schirinzi vuole sbarazzarsi del sociale, di tutto quell’apparato che nasconde la tragicità della vita sotto le scartoffie, per far riaffiorare una nuova percezione delle cose, o forse antica, che si riaffacci alla vita e ai suoi problemi partendo dall’uomo, che in questo momento non può che essere fantasma. Il problema della clandestinità perde il connotato problematico e diventa una sorta di isola semantica da avvicinare e conoscere.
Come si può evincere che la connotazione politica di tale tendenza cinematografica sia molto forte, sviluppandosi in una forma che chiama in causa uno spettatore attivo. È una condizione inevitabile stabilire un terremoto percettivo per ricreare un rapporto nuovo tra spettatore e film. E questo comporta fatica. Il cinema politico classico, come il pubblico lo intende, è di solito il cosiddetto cinema di denuncia, che ha nella catarsi del terzo atto il suo apice, la commozione, per poi lasciarci liberi. È, se vogliamo, l’aver trasposto i più logori meccanismi narrativi della letteratura nel linguaggio audiovisivo, addomesticandolo, ed era già così agli albori del cinema (e subito tutto il resto diventò "surrealismo") e pare che poco sia cambiato. Nel nostro cinema del reale il politico è nel linguaggio stesso e nel suo porsi; in una forma, se vogliamo usare questo termine, di secondo grado, in cui il reale diviene la narrazione e il suo contrario, metonimia di un tutto eternamente mancante, del quale lo spettatore attento, attivo, deve cogliere il vuoto. Il rapporto diretto con il reale spesso lo fa coincidere con il genere documentario: ma attenzione, nulla a che fare con il semplice “girare dal vero”. Il rapporto che l’autore instaura con il film e con il pubblico è fondamentale, il suo ruolo di artigiano, la sua capacità, il suo stile permettono di rendere visibile l’essenza, poi forgiata in una forma; proprio come fa un distillatore, che dagli scarti dell’uva, che la natura ci dona come cibo, fa nascere un liquore ottimo capace di stordire (e perciò di variare la percezione di ciò che ci sta intorno). Siamo nei casi più estremi, per capirci, più dalle parti del cinema di Straub-Huillet che del documentario puro, alla ricerca della sostanza delle cose. Una ricerca, un potere, che i più illuminati già individuavano agli albori del cinema, come dice Rancière parafrasando Delluc: “Esso non riproduce le cose così come vengono a offrirsi allo sguardo, ma le registra piuttosto nel modo in cui l’occhio umano non le vede, ossia così come avvengono, sotto forma d’onde e di vibrazioni, prima che possano essere qualificate come oggetti, persone o eventi identificabili in funzione delle loro proprietà descrittive o narrative. L’arte delle immagini in movimento […] è una porta aperta su di una verità interna al sensibile” (da Rancière, La favola cinematografica, Pisa, Edizioni ETS).

Ma vediamo di capire perché il documentario non coincide sempre con il cinema del reale, cosa che dovrebbe essere naturale. Senza che ce ne accorgiamo, il cinema documentario spesso si cristallizza in un genere con regole ferree di percezione che, giocando sulla (finta) oggettività del rappresentato, guida la passività dello spettatore verso un giudizio. Mi si passi questo esempio volutamente un po’ forte e provocatorio. Pensiamo ai vari documentari su Carlo Giuliani, primo tra tutti quello di Francesca Comencini, Carlo Giuliani, ragazzo: le immagini dell’evento si alternano all'intervista alla madre del ragazzo. Il montaggio è decisamente al servizio delle parole della madre, ritmandone il discorso e sottolineandone le opinioni attraverso immagini che incarnano le parole (scelte tra migliaia e migliaia di immagini): la tesi proposta è assolutamente sostenuta, evitando qualunque divagazione. Ora, al di là del valore sociale del film, siamo davanti a un cinema che poco si allontana da una creazione di fiction. L’impressione di realtà, dovuta al bisticcio interpretativo del genere documentario da parte del pubblico, che crede ciecamente all’assioma documentario/verità, è sfruttata per perorare un'opinione già scritta. La selezione delle scene montate va sempre e solo in una direzione, elidendo tutto ciò che è fuori dalla sceneggiatura (le parole della madre, il senso comune di una parte politica) e non fa che rafforzare l’idea di un'unica via, accompagnando lo spettatore ancora più nella passività, proponendogli direttamente “la spiegazione”. Un cinema che vorrebbe entrare nella realtà e che invece sposa una tesi. In questo (mi si passi il termine un po’ forte) disonesto. Niente di sbagliato socialmente, soprattutto in simili casi in cui c’è di mezzo la sensibilità di una madre e un delitto. Ma la ricezione del genere documentario come certezza, foriero di una (fasulla) verità al grado zero che spera di essere una risposta (ma può esistere una verità “montata”? Roberto Rossellini docet), è sbagliata. Ovviamente il film vuole agire su altri livelli, sposando una tesi scomoda e insabbiata dalla maggior parte dei media, sottolineando parti della vicenda spesso solo abbozzate dalla stampa. Ma resta un pamphlet civilmente nobile: se il suo scopo è quello, lo raggiunge, esattamente come avrebbe potuto fare un’inchiesta giornalistica o una trasmissione radiofonica. Non c’è un’immersione nell’esistenza delle cose, nel loro tempo; il documentario di Comencini agisce in superficie, legalmente, diciamo così, costituzionalmente. Diviene parte civile in un processo. Forse necessario. Ma il cinema è un’altra cosa.

Il cinema del reale deve invece far risuonare il reale, guidare le coscienze verso la scoperta di quello che non può essere governato, del potere stesso delle cose. Prendiamo un altro film, di quasi dieci anni dopo, che mette in scena, tra le altre cose, gli imponenti scioperi degli operai della Innse Metal Meccanica di Milano, contro un licenziamento assurdo. Cielo senza terra di Giovanni Maderna è un film imperfetto, tanto semplice quanto debordante, che ha il grande pregio di cercare di purificare il linguaggio partendo dal basso, dal filmino di famiglia, l’home movies. Non più però il found footage dei nonni di tanti esperimenti, ma mettendolo direttamente in scena, attraverso un viaggio sui monti di un padre con il proprio figlio (il regista stesso e suo figlio) ripresi con una videocamera a spalla, che passa tra le mani di entrambi ed è sostenuta da una filmmaker la cui presenza non è mai nascosta. Un racconto semplice e minimale che fruga tra le gemme nascoste di un rapporto diretto tra persone e cose, al quale viene contrapposto quello che succede a valle, a Milano, ossia gli scioperi dell’Innse (nel montaggio alternato sta, semplicemente, senza intellettualismi, la dimostrazione dell’impossibilità della spontaneità assoluta). Maderna non cambia registro in città, ma cerca di seguire con la videocamera il suo istinto, cercando i sentimenti e le imprevedibili atmosfere dello sciopero, così come cerca i guizzi fulminei e gli umori del figlio e del rapporto, ora tenero ora conflittuale, con il padre. Dettaglio importante è che in entrambi i casi sono evidenti i limiti che il regista ha e soprattutto vuole avere: non entra mai senza chiedere permesso, le forze sue e solo le sue e dopo il cinema. Un film parziale, che cerca di tenere lontano il giudizio, assolutamente incompleto, ma che trova la propria forza nel rapporto tra i piccoli moti umani della gioventù del figlio e la scalata faticosa, e forse un poco noiosa, contrappunto del percorso degli operai milanesi, anch’essi issati (è il caso di dirlo, alcuni manifestavano su un’altissima gru) verso la vita e stanchi di lottare. Un film diametralmente opposto a quello della Comencini, fatto non per chi cerca risposte, e nemmeno vuole darne, ma per chi vuole provare a vedere, anche solo il proprio naso. I licenziamenti e gli scioperi sono tutti uguali se non si è ferrati in materia, l’aria che si respira è sempre differente. Al cinema.

Difficile raccogliere i film citati sotto un'etichetta: è evidente il coinvolgimento dell'autore nel filmico e nel profilmico, per questo è un cinema fortemente antropologico, che fa del dubbio interpretativo il fondamento. Si possono applicare a queste opere i dettami di Clifford Geertz o James Clifford sull’impossibilità di sfuggire uno stile: quando si fa indagine scientifica, si fa comunque letteratura, quando ci si pone di fronte all’altro, si affabula, si passa attraverso un filtro. “L’osservazione partecipante costringe coloro che la praticano a sperimentare, a livello sia fisico, sia intellettuale, le vicissitudini della traduzione” (Clifford, I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel XX secolo, Torino, Bollati Boringhieri 2010). Ma se per gli antropologi a volte è un pericolo, sembra che per il nostro cinema attento al reale sia un passaggio positivo; cercare a lato e nel cercare stesso lo scopo, il racconto.
I precursori di questo tipo di cinema ci sono e sono molti. L’inizio dell'inconscia ricerca avviene nel grande cinema italiano di un tempo: il Neorealismo, Rossellini su tutto, vero precursore del cinema del reale. Anche qui, non il realismo, non la storia partigiana o di solitudine in sé, ma l’attenzione al risvolto apparentemente insignificante che apre squarci inediti (come sottolinea Deleuze ne L’immagine-Tempo). Ma la grande rivoluzione arriva con i cambiamenti tecnologici che permettono costi sempre minori e possibilità di girare in situazioni difficili e tempi brevi. E soprattutto consentono di filmare molto e con meno membrane tra il filmante e il filmato. Mai come ora la tecnica è una morale.
Dall’arrivo del digitale negli anni Novanta il reale è diventato più interessante da filmare e far debordare: il poter usare la cinepresa nell’intimità, come una penna, cambiando così il rapporto con il soggetto, con la scrittura, con la macchina cinema tutta. Ad esempio, Corso Salani che ha trovato un suo modo di girare storie d’amore con il video e con i primi mezzi digitali creando dei menage à trois tra macchina da presa e coppia, dove il personaggio e l’autore si confondono continuamente, e che ha in Imatra, parte della serie Confini d’Europa, forse l’esempio migliore.

La tendenza oggi all’autoproduzione ovviamente è forte, si sceglie la totale indipendenza per evitare di attendere i tempi tecnici, ormai biblici, che una produzione richiede (come minimo due anni). Seguendo questa via un po' selvaggia alcuni autori sono riusciti a portare a galla situazioni difficili che andavano colte al volo, senza però perdersi nella banalità, ma facendo di necessità virtù. Un esempio è Angeles City, Philippines di Davide Arosio e Alberto Gerosa. Durante un lavoro nelle Filippine i due registi incappano in Angeles City, ex base NATO e grande bordello a cielo aperto, che inaspettatamente apre loro brecce in cui entrare. Si buttano tra prostitute e puttanieri con la loro videocamerina amatoriale, mantenendo un linguaggio deciso e studiato, alla ricerca di un terribile mondo sotterraneo (ma con punte di un candore abbagliante) che li accoglie non capendo bene se i due siano turisti, giornalisti, cineasti o voyeur. Come avrebbero potuto con una troupe? Ritornando con una produzione avrebbero ritrovato ancora tutto?
Questo cinema, così fiorente e interessante oggi in Italia, resta purtroppo un cinema di nicchia, e non solo per la sua vocazione provocatoria ma soprattutto per via di una quasi totale assenza di un circuito di distribuzione. I film, persino i più fortunati, vengono proiettati ai festival, a qualche rassegna, quasi più all'estero che da noi (i film della coppia D'Anolfi e Parenti, Il castello e Materia oscura, ne sono un chiaro esempio: premiati e invitati in tutto il mondo, invisibili in sala da noi). Pochissimi hanno una distribuzione: un caso fu La bocca del lupo di Pietro Marcello, coraggiosamente portato il sala dalla Bim, senza ottenere i risultati sperati per via della mancanza di un vero e proprio circuito. E qui la seconda parte della metafora che ho usato all’inizio, “un’aria poco respirabile”: il rischio è l’autoreferenzialità. La difficoltà di fruizione, o meglio di attenzione, non aiuta lo spettatore ad entrare in sala e la diffusa autoproduzione non aiuta il prodotto a essere distribuito né nelle sale né in tv, creando un preoccupante circolo vizioso. Ma, in un certo senso, è giusto che sia così. O, meglio, per ora dobbiamo accontentarci. Un cinema che richiede un po’ di sforzo, chiamando in causa uno spettatore non troppo abituato a questo ruolo, non è certo quello che porta incassi nel nostro paese ancora legato all'idea dell'industria cinematografica, sempre più fantasmatica.
Non sono un critico, dicevo, e non credo di essere un’analista. Ma quest’aria che odoro la sento veramente, se fossero anche soltanto aliti di vento, sta a ciascuno di noi decidere di andare un po’ più a fondo.