1.
Anche lasciando per un attimo da parte la qualità del film in sé – sulla cui straordinarietà torneremo in seguito -, basterebbe leggere alcune delle recensioni con le quali è stato accolto in Italia Inside Out per constatare come il film sia riuscito a smuovere, del nostro immaginario, qualcosa di assolutamente eccezionale. Non capita spesso, infatti, né di assistere a spavalde difese di concetti maldestramente argomentati quali il “libero arbitrio”, né di vedere convocate paranoiche rappresentazioni degli studi Pixar come catene di montaggio dedite alla manipolazione delle coscienze degli spettatori. È vero: Inside Out è stato un successo senza precedenti di pubblico e di critica, ma se proviamo a leggere alcune tra le recensioni più teoriche e tra le riflessioni più meditate non si può non notare che alla fine, nonostante tutto, qualcosa di questo film ha finito lo stesso per risultare fastidiosamente scomodo e perturbante. In molte di queste reazioni pare leggere: com’è che una questione così complessa e fondamentale per la storia delle arti e della filosofia come la coscienza, l’interiorità o la soggettività può essere rappresentata tramite qualcosa di così triviale, e in fondo stupido, come dei piccoli pupazzetti che sarebbero alla guida delle nostre azioni? Secoli e secoli di speculazioni sulle scelte soggettive, sui tormenti e le aporie dell’interiorità, sul rapporto tra l’uomo e il destino etc. possono davvero essere spiegati con una serie di “emozioni” pre-soggettive che starebbero nel nostro cervello e lo guiderebbero come se fossero in una stanza dei bottoni?
In effetti basterebbe provare a fare un esercizio mentale e applicare i protagonisti di Inside Out ad alcuni eventi della nostra storia, collettiva o personale, per provare un filo di disagio: quando abbiamo incontrato un fallimento è perché Paura ha preso il sopravvento su Gioia? Quando è subentrato un conflitto è forse perché Rabbia ha preso possesso della nostra consolle dei comandi e ha fatto deragliare la nostra voglia di dialogo? Quando ritorniamo con la mente a un evento passato e ci assale la malinconia è perché Tristezza ha occupato uno dei Ricordi Base? Chi è che dunque ha preso davvero quelle scelte? Siamo stati noi o è stato qualcosa che sta prima (o dentro) di noi e che ci guida nel nostro stare al mondo secondo i propri imperscrutabili criteri?
Non è la prima volta che la coscienza viene rappresentata come una stanza dei bottoni governata secondo principi che non scegliamo e ai quali dobbiamo sottostare. Prima ancora della cibernetica, fu già Julien Offray de La Mettrie nel Settecento a pensare che l’anima potesse essere spiegata da un punto di vista puramente materialistico e macchinico. Ma naturalmente si è dovuto aspettare gli anni Sessanta e Settanta del Novecento per assistere al grande successo delle scienze cognitive che hanno definitivamente requisito il concetto di coscienza e soggettività al regno della filosofia. Ormai la perfetta integrazione tra le scienze cognitive e quelle naturali è diventata senso comune a tal punto che non sorprende trovarla persino in un film d’animazione per pre-adolescenti. Nonostante molti umanisti fuori tempo massimo abbiano reagito e continuino a reagire alle scienze cognitive con un misto di orrore e repulsione, la domanda che emergerebbe in modo implicito, e tuttavia incredibilmente chiaro e radicale, anche da Inside Out, è invece imprescindibile per ogni filosofia degna di questo nome: dove sarebbe il luogo della nostra soggettività o della nostra coscienza? È forse nelle nostre sinapsi neuronali? È in un inafferrabile e misticheggiante spirito? Dov’è il luogo della nostra anima o del nostro inconscio? Dove siamo dunque noi?
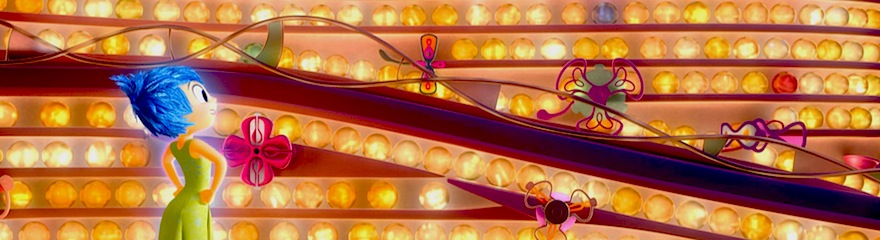
2.
È allora interessante notare come si esprima – in modo svergognatamente diretto – Goffredo Fofi nella sua recensione del film su Internazionale: “è insomma – forse esagero, ma forse no – come se, partendo non a caso dai bambini, un potere nuovo voglia abituarci all’idea di una nostra dipendenza da entità astratte ma ben presenti nella realtà, e voglia abituarci ad agire di conseguenza, assistiti e guidati da chi pensa per noi e ci spinge dove vuole lui.” Una frase che non può che suonare famigliare, quanto meno a chi abbia qualche dimestichezza con la psicoanalisi. Perché c’era già in effetti arrivato qualcuno a dire che il desiderio – cioè quello che esprime nel modo più singolare la nostra soggettività – non ha nulla dell’inafferrabile interiorità, ma che è “guidato” da una batteria di “entità astratte” e discrete chiamate significanti. Ed era, evidentemente, Jacques Lacan. Così come a dire che non siamo più padroni in casa nostra – e che il “libero arbitrio” esiste solo in quella fiction che è l’immaginario – non ci voleva certo Inside Out, ma c’aveva già pensato la psicoanalisi più di un secolo fa. La reazione “umanistica” al film della Pixar è allora il frutto di una delle ideologie più in voga nelle Scienze Umane contemporanee: quella che vede con un occhio di sospetto il programma di demistificazione messo in atto dalla scienza moderna. Ed è tanto più interessante proprio perché inconsciamente viene riconosciuto, come già ricordava Freud, che il più grande colpo inferto allo narcisismo antropologico della tradizione umanistica è stato dato dalla scienza galileo-newtoniana, dalla psicoanalisi e dal marxismo.
Ma se Inside Out va a toccare i nervi scoperti di un’idea ancora spiritualista o misticheggiante di soggetto come entità irriducibile alla materia, bisogna tuttavia anche evitare di fare del film un’apologia di una riduzione della soggettività alla trasparenza oggettiva delle emozioni materiali. Questa lettura, apparentemente non priva di appigli nel film, è figlia di quel grande equivoco che è la diffusione nelle Scienze Umane contemporanee della cosiddetta “affect theory”. Si tratta di una serie di pensatori che riallacciandosi in modo spregiudicato alla tradizione Spinoza-Nietzsche-Bergson-Deleuze hanno elaborato una strana forma di antropologia materialistica secondo cui ciò che definisce più propriamente un soggetto non è la dimensione linguistico-razionale (che sarebbe troppo legata all’universalità “normativa” della cultura) ma una sorta di intensità corporea pre-significante e pre-razionale che chiamiamo affetto. Secondo Brian Massumi, uno dei filosofi deleuziani più di successo degli ultimi anni, “gli affetti sono pre-personali… Un affetto è un’esperienza d’intensità non-cosciente; è un momento di una potenzialità senza forma e senza struttura… Un affetto non può esprimersi pienamente nel linguaggio, perché un affetto è sempre prima o al di là della coscienza”. Massumi, così come Eve Kosofsky Sedgwick o Smail, si riallacciano a una tradizione molto discussa (e variamente contestata) nelle scienze biologiche che va da Silvan S. Tomkins, a Paul Ekman, a Joseph LeDoux e che sostiene la presenza di un numero vario ma definito di “programmi affettivi” (dai 6 ai 9) localizzati sotto la corteccia cerebrale e definiti in termini evoluzionistici come universali o trans-culturali. I nomi dovrebbero esserci famigliari: Paura, Rabbia, Disgusto, Gioia, Tristezza, Sorpresa (a volte viene aggiunto Vergogna, Angoscia, Percezione di cattivi odori etc.) di solito legati a una particolare espressione facciale che indipendentemente dal contesto culturale e dalla storia personale verrebbero sempre ad attivarsi in seguito ad alcuni stimoli corporei. Il linguaggio e il simbolico – a parer loro, strutture culturali estrinseche e artificiose – andrebbero a posarsi in modo illegittimo su una corporeità che invece seguirebbe un binario autonomo e slegato da qualsivoglia intellegibilità cognitiva da parte del soggetto. L’apparente infarinatura di letteratura scientifica di un Massumi non dovrebbe trarci in inganno, perché anche qui ciò che salta all’occhio è innanzitutto il grande rifiuto di qualsivoglia progetto razionalista in nome di un primato del corpo e della sua irriducibile autonomia.
Deleuze, purtroppo, è sempre più spesso convocato come autore passepartout per rivendicare un generico primato dell’intensità contro la distinzione razionale, del corpo contro il pensiero, della qualità contro la quantità, del concreto contro l’astratto, della vita contro la finitudine etc. Non è questa la sede per sottolineare come l’ontologia deleuziana, legata in modo così esplicito all’univocità dell’Essere cozzi in modo plateale con un’interpretazione antropologica tanto dualista (rimandiamo a questo proposito alla recensione del libro di Rocco Ronchi su questo speciale): ci basti però sottolineare quanto Inside Out scarti esplicitamente entrambe le ipotesi: sia evidentemente quella spiritualista incentrata sul “libero arbitrio”, sia quella pseudo-deleuziana incentrata sul paradigma dell’affect theory.

3.
Quale sarebbe allora l’idea di coscienza e di soggettività che emerge da Inside Out? Perché se è vero che nell’epoca del successo delle scienze cognitive non è troppo complicato rigettare l’ipotesi di un soggetto “irriducibile” alla propria base biologica, perché allora il paradigma dell’affect theory e dei 6, 7 o 8 “programmi affettivi” sottocorticali sarebbe anch’esso da rifiutare?
Il problema non può che essere posto a partire da una basilare questione epistemologica: se è vero che un soggetto può essere studiato a partire dalla sua base biologica e materiale come sostengono le scienze cognitive – possiamo ad esempio studiare le sinapsi e le reti neuronali di un individuo – da dove nasce quella domanda? Chi guarda quelle reti neuronali? È sempre a partire dalla capacità di comprensione data dalle nostre reti neuronali – ad esempio quelle di uno scienziato cognitivo che studia il comportamento di un individuo – che noi possiamo “oggettivare” i “programmi affettivi” sottocorticali e ridurli ad un dato empirico che può essere studiato. Il problema allora è: com’è che la mente comprende sé stessa? O meglio, com’è che la materia comprende sé stessa? Che la materia guarda sé stessa? Se un soggetto è completamente riducibile alla sua corporeità, com’è che la sua corporeità guarda e comprende sé stessa? Questo problema dell’auto-riferimento della materia a sé stessa è proprio ciò che Hegel (ma il Deleuze de La piega fa praticamente la stessa cosa) chiama un soggetto.
In Inside Out tale questione si esprime in due modi: innanzitutto i diversi “programmi affettivi” non sono materia inerte che risponde secondo un principio causale meccanico alle stimolazioni esterne – come invece vorrebbe Massumi –: Gioia, Tristezza, Paura etc. sono anch’essi dei “soggetti in piccolo”. La questione dell’autoriferimento soggettivo non è allora eliminata in nome di un materialismo degli affetti, ma è spostata dall’immaginaria coscienza dell’individuo alla “coscienza” dei singoli affetti (e allora ci verrebbe da chiedere: chi controlla la consolle di Gioia o di Tristezza? In base a quali principi?). La scissione soggettiva, alle quale ci ha abituato la tradizione umanistica delle tragedie di Sofocle, del Don Quixote o dei romanzi di Proust, non è “risolta” ma è solo riportata a un altro piano. Non c’è il principio primo che potrebbe spiegare in modo definitivo l’enigma della coscienza; non c’è una fondazione materiale al libero arbitrio, né una spirituale. La questione è allora quella di costatare come il problema delle condizioni fondamentali della coscienza – che riguarda Riley tanto quanto Tristezza – sia semplicemente la figura di una scissione fondamentale o ontologica. Più andiamo a cercare un principio primo che possa fondare la soggettività, più finiamo col trovare continuamente una scissione, e poi una scissione della scissione, e così via.
Ma Inside Out ha anche un altro modo per esprimere l’autoriferimento della materia emozionale, ed è l’equivocità fondamentale dei ricordi: alla fine del film non esistono ricordi gioiosi o tristi. In quello che è nientemeno che il momento risolutivo dell’intero arco drammatico, Gioia prende in mano una sfera-ricordo colorata di giallo, il colore che dovrebbe segnalare “felicità”. Vi si vede Riley che viene portata in trionfo dai suoi compagni di squadra di hockey. Quando peró Gioia scorre con la mano sulla sfera, vengono visualizzati i momenti appena precedenti, e si tratta di momenti tristi, dunque colorati di blu: Riley, depressa per aver mancato il punto decisivo e per avere così portato la propria squadra alla sconfitta, viene consolata dai genitori – poco prima, appunto, che l’intera squadra le si avvicini per consolarla, riuscendo così a capovolgere il suo umore. Questo ricordo, dunque, non viene caratterizzato univocamente da un’emozione che sarebbe intrinsecamente sua. I ricordi sono un impasto equivoco e ambiguo di diverse emozioni. È la materia stessa a essere equivoca e non esplicativa. O detto in altri termini, è la materia stessa a essere fondamentalmente scissa.
Del momento decisivo in cui, nel film, Gioia matura questa consapevolezza davanti alla sfera, va sottolineato anche un altro aspetto: in Inside Out, il ricordo di quella giornata tutto sommato felice ma sfortunata non si lascia qualificare da una qualsivoglia emozione. Di Paura, Rabbia, Disgusto e quant’altro, non c’è traccia. Sono solo due a giocarsi quel ricordo: Gioia e Tristezza. E in definitiva queste ultime sono quanto di più vicino possa esserci, in un film il cui target principale (benché per nulla esclusivo) sia quello infantile, a quell’altra coppia che tanta parte ha avuto nei tentativi di quest’ultimo secolo di spiegare “come è fatta l’interiorità”: Eros e Thanatos.
.jpg)
4.
Ecco dunque che in un film che parrebbe intriso di riflessioni prese dalle scienze cognitive, rispunta fuori in primissimo piano il vecchio Al di là del principio di piacere freudiano, antecedente illustre di quell’equivocità del significante che caratterizzerà il pensiero di Lacan. L’illusione che l’equilibrio omeostatico del principio di piacere regoli la totalità della psiche (Gioia che, nelle prime scene, “dirige” gli affetti e confina Tristezza dentro un cerchio da cui non può uscire), cede il passo alla consapevolezza che c’è qualcosa di squilibrato e profondamente asimmetrico che rimane fuori dal suo raggio, ovvero l’impulso alla ripetizione: perciò, è piuttosto nell’intreccio squilibrato tra Eros e Thanatos (perché non complementare) che va cercata la chiave della vita psichica. Ed è davvero usando come bussola quello straordinario testo freudiano che Inside Out rivisita le concezioni contemporanee della psiche. Nel film, gli affetti (Rabbia, Paura, Disgusto) sono mostrati alla consolle di comando della nostra mente: si tratta, però, soltanto di un’illusione temporanea. L’ipotesi che l’interazione tra gli affetti sia davvero ciò che spiega deterministicamente il nostro comportamento vive solo per quel lasso di tempo che serve a Gioia e Tristezza, ovvero a Eros e Thanatos, per trovare una reciproca articolazione nella scissione. È articolandoli insieme, infatti, che Riley riesce a far fronte a quella piccola grande catastrofe che è la pre-adolescenza: quell’età in cui siamo chiamati a fare i conti col fatto che ripetere l’infanzia è non solo impossibile, ma anche necessario. È impossibile perché l’infanzia è, banalmente, irripetibile. È necessario perché la vita adulta stessa è sostanzialmente un gioco: è con una partita di hockey che viene salutato il definitivo abbandono all’infanzia da parte di Riley – quando gli umori a ruota libera dell’ “età difficile” tornano ad essere disciplinati dall’abbraccio dialettico tra i due opposti fondamentali.
Ma se la vita è un gioco, non c’è molto da stare allegri. E Inside Out non lo nasconde affatto – tutt’altro. Il padre di Riley non sembra affatto a suo agio dentro un capitalismo in piena mutazione postfordista, quella mutazione che – così vuole la vulgata – abbatterebbe la separazione tra il tempo di lavoro e il tempo libero, e che nei fatti sballotta il capofamiglia (e dunque la famiglia stessa) all’altro capo degli States sottomettendolo, ci pare di capire dalle telefonate con capi e/o colleghi, a una sostanziale precarietà e ai poco prevedibili capricci della finanza (“il capitale basterà per un mese, forse due, se non troveremo finanziatori dovremo licenziare delle persone…”). Qui il livello “metapsicologico” di Inside Out si fonde con quello storico. L’ “affect theory” è solo l’illusione ideologica che meglio sembra attagliarsi al nostro presente, fase di assestamento tra due epoche e in quanto tale avvicinabile alla pre-adolescenza di Riley. Che gli affetti siano effettivamente al timone non è “la teoria del futuro”, ma solo un’illusione teorica passeggera destinata a lasciare spazio, come sempre, a una nuova riconfigurazione della vecchia dicotomia Eros/Thanatos o dell’equivocità significante.

5.
Lo si è detto fin troppe volte: stiamo entrando in un’era digitale. E del resto buona parte delle opere Pixar (i vari Cars, Up!, Wall-E…) sono molto chiaramente e molto precisamente tentativi di negoziazione del difficile abbandono del mondo che ruotava intorno alla fabbrica. Ma Inside Out sembra suggerirci che proprio l’ottica apparentemente sorpassata di Al di là del principio di piacere sia in realtà quella più adatta per affrontare questa mutazione. Gioia scopre quanto inseparabile lei sia da Tristezza non solo guardando le immagini dentro la sfera del cruciale ricordo equivoco, ma anche e soprattutto toccandole, scorrendole con le dita esattamente come un qualsiasi dispositivo touch-screen.
Il cinema, ovvero il passato, è invece riservato a quella vecchia concezione della psiche che volgarizza il lascito freudiano in qualcosa di sostanzialmente inservibile, ovvero a quella concezione ingenua che sopravvaluta i sogni per i motivi sbagliati, e considera la produzione onirica un “frullato” di esperienza vissuta prodotto per condensazione e spostamento. In Inside Out, i sogni sono prodotti in uno studio cinematografico, la Dreams Productions, che rimette obliquamente in scena la vita diurna di Riley. Non può sfuggire lo sferzante sarcasmo che il film riserva a queste bislacche “riprese”. E in un certo senso è anche giusto così: per quanto gloriosa, la Hollywood classica “peccò” assai di frequente di deliberata volgarizzazione della psicanalisi, ridotta a determinismo di bassa lega per cui il comportamento umano sarebbe il prodotto diretto di una serie di traumi ricostruibili “narrativamente”.
Ma ciò che più importa, è che allo stesso modo non puó nemmeno sfuggire il fatto che in Inside Out l’incursione negli studi della Dreams Productions, e dunque la produzione onirica in generale, ha una sola funzione e un’unica finalità: il risveglio, condizione necessaria affinché Gioia e Tristezza proseguano il loro viaggio. È addirittura l’inconscio in quanto tale ad avere, nel film, quest’unica funzione e quest’unica finalità: è una grotta in cui non c’è niente tranne alcune cose a caso (broccoli giganti) e un gigantesco clown dormiente, il quale è lì solo in quanto unica causa potenziale del risveglio di Riley. In definitiva, dunque, i sogni non contano tanto in quanto rappresentazioni di qualcosa, e non è dal lato della rappresentazione che vanno presi: proprio come la rappresentazione in generale vede nella propria interruzione l’elemento decisivo che la fonda, i sogni, se visti come rappresentazioni di qualcosa, sono interamente verticalizzati e polarizzati in direzione del solo momento del risveglio – e infatti la pantomima inscenata dalla Dreams Productions ha senso solo in funzione delle sue due interruzioni: prima quando Gioia e Tristezza irrompono sul set dentro il costume da cane, e poi quando il clown sconvolge le riprese. E non può essere che così, dal momento che il fenomeno-chiave della coscienza, a proposito del quale ci si è già dilungati più sopra, è non già il suo venire generato dal libero gioco degli affetti, ma quell’auto-riferirsi attraverso cui questo stesso libero gioco viene alla luce. E tra le possibili figure di questo auto-riferirsi, il risveglio è senza dubbio tra le più calzanti.
La conferma di quest’ipotesi è fornita da una delle prime scene di Inside Out. Ben prima che Gioia e Tristezza visitino gli studi della Dreams Productions, Riley sogna, e sogna due sogni di seguito. Il primo è un ridicolo “frullato” di esperienze vissute il giorno prima, di cui il film stesso si fa beffe apertamente. Con il secondo, da farsesco il tono diventa improvvisamente solenne: Riley pattina sullo “schermo della mente”, e Gioia ne segue pari pari i movimenti pattinando davanti al medesimo schermo. Ciò che conta, nei nostri sogni, non è la raffazzonata meccanica della condensazione e dello spostamento simbolici dei dati esperienziali, non è la produzione di anagrammi in codice, ma è la cristallizzazione dell’auto-riferirsi della coscienza, il prendere forma di questo “piegarsi” su se stessa della materia senza mai poter coincidere.
Ma c’è di più. Sui set della Dreams Productions non vengono utilizzati attori, ma “affetti”, che come i vari Paura, Disgusto e Rabbia alla consolle di comando non sono che forme colorate con un volto vagamente antropomorfo, le quali assumono sembianze umane solo perché davanti all’obbiettivo della cinepresa che li “filma” viene posto un “filtro impressione di realtà”. Le implicazioni di questa geniale incursione nel metacinema sono chiare: con il freudismo “volgare” che vede nel sogno una specie di “frullato” della realtà ordinariamente esperita, e che riecheggiò così a fondo e in tanti modi in quella “macchina dei sogni” per eccellenza che fu la Hollywood classica, “affect theory” e simili condividono una medesima, fallace inclinazione determinista. Laddove un approccio vede il sogno come il semplice prodotto di un processo tutto sommato meccanico di rielaborazione simbolica che potrebbe persino essere ricostruito “narrativamente”, linearizzando cause e effetti, l’altro vede la personalità e il comportamento alla stregua di semplici effetti di cause ben definite, e magari cause a propria volta di altro, in ogni caso momenti di sistemi di catene causali tutto sommato intellegibili. Questo, insomma, sembra suggerirci Inside Out: a essere antiquato come oggi sembra esserlo il cinema sarebbe proprio questo approccio teorico così apparentemente contemporaneo, mentre è invece il vecchio Al di là del principio di piacere, come si è visto più sopra, a poter dire ancora utilmente la sua.

6.
È qui che rientra in gioco Deleuze. Ma si tratta di un Deleuze che non ha nulla a che vedere con quello dell’ “affect theory” di Brian Massumi. Il capolavoro freudiano è tutt’altro che estraneo alla filosofia deleuziana: nella sua prima fase, quella ad esempio di Logica del senso o, soprattutto, Differenza e ripetizione (ma anche, più tardi, i suoi due libri sul cinema), Al di là del principio di piacere è una sorta di motore occulto, sulla cui importanza Deleuze ha spesso minimizzato ma che nondimeno ha attecchito nelle radici più profonde del suo pensiero. Un piccolo, sfortunato libro di Slavoj Žižek di una decina di anni fa, Organs without Bodies (Organi senza corpi), aveva cercato senza troppo successo (per ammissione stessa del suo autore) di tracciare i contorni di un Deleuze “freudo-hegeliano” che potesse fungere da antidoto ai vari cognitivismi oggi tanto in voga. Žižek aveva cercato, insomma, di vedere in ciò che ci ha lasciato Deleuze un formidabile strumento per superare (come peraltro Deleuze stesso ammise di voler fare) la fallace opposizione tra materialismo e idealismo in cui rimangono ancora impigliati tutti quelli che, gravitando variamente intorno all’ “affect theory”, spesso si sono serviti di Deleuze cercando di “depurarlo” dalla negatività autoriflessiva freudo-hegeliana per conservarne invece l’enfasi “materialista” sull’autonomia degli affetti e sulla loro dimensione produttiva. Già dalla prima scena, Inside Out sposa in pieno l’ipotesi che Deleuze ricavò (fra gli altri) da Cartesio e Bergson, distorcendoli sfacciatamente ma proficuamente: quella dell’analogia tra la coscienza e lo schermo cinematografico (quello su cui, a pochi minuti dall’inizio, Gioia guarda i genitori di Riley mentre osservano gli occhi appena aperti della figlioletta neonata). Dopodiché, il film prende atto di ciò che è diventato il deleuzismo oggi, mettendo gli affetti e la loro interazione direttamente alla consolle di comando del soggetto; in ultima analisi, tuttavia, esso finisce per ripercorrere il tracciato post-deleuziano abbozzato qualche riga fa a ritroso, partendo dalle teorie contemporanee della mente per arrivare infine ad Al di là del principio di piacere, riuscendo in scioltezza là dove il volume žižekiano si è limitato ad arrancare.
Molti ricorderanno la folgorazione che anni fa Žižek confessó per Kung Fu Panda. Forse l’errore fu quello di volgersi verso la DreamWorks, anziché verso il più autorevole degli studi di animazione concorrenti.